Si è conclusa la settimana dell’assegnazione dei prestigiosi premi decisi dal Comitato Nobel di Stoccolma e dal Comitato norvegese per la Pace di Oslo. Come ogni anno, questi riconoscimenti non solo premiano risultati di straordinario rilievo, ma disegnano anche una mappa simbolica delle direzioni verso cui si muove la scienza, la cultura e l’umanità stessa.
Il calendario dei Nobel segue una scansione ormai consolidata: si comincia con la Medicina e Fisiologia, si prosegue con Fisica, Chimica, Letteratura e Pace, per concludersi con il Premio per le Scienze Economiche in memoria di Alfred Nobel, istituito successivamente dalla Banca di Svezia.
Medicina 2025: tolleranza immunitaria periferica
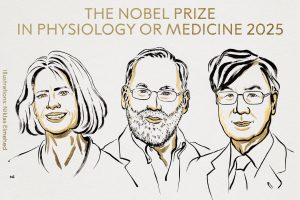
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi
Il Premio Nobel per la Medicina 2025 è stato assegnato oggi a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi «per le loro scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica», che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l’organismo ed evitare di attaccare i tessuti sani.
Le loro ricerche hanno portato all’identificazione delle cellule T regolatrici e alla comprensione del ruolo del FOXP3, elementi fondamentali per mantenere l’equilibrio immunologico dell’organismo.
Questo lavoro ha aperto la strada a terapie potenzialmente rivoluzionarie contro le malattie autoimmuni e a trattamenti oncologici più mirati, capaci di modulare la risposta immunitaria. Anche i protocolli di trapianto potranno beneficiare di queste scoperte, migliorando la compatibilità e riducendo i rischi di rigetto.
Molti dei trattamenti derivati da queste ricerche sono oggi in fase di sperimentazione clinica, confermando l’impatto duraturo di una scoperta che unisce rigore scientifico e applicazione medica concreta.
Fisica 2025: la quantistica oltre i microscopi

John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis
Il Premio Nobel per la Fisica 2025 è andato a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis «per la scoperta dell’effetto di tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico».
I tre fisici hanno dimostrato come i principi fondamentali della meccanica quantistica possano manifestarsi anche in sistemi su scala macroscopica, visibili e manipolabili. Attraverso esperimenti su circuiti superconduttori e giunzioni Josephson, hanno evidenziato che le proprietà quantistiche – come il comportamento onda-particella e i salti energetici discreti – non sono confinati al mondo subatomico.
Questa scoperta rappresenta un passo avanti decisivo per lo sviluppo dei computer quantistici, dei sensori ultra-precisi e di dispositivi basati sulla coerenza quantistica. Le applicazioni tecnologiche di questi studi potrebbero ridefinire l’elettronica e la comunicazione dei prossimi decenni, aprendo la strada a una nuova era della fisica applicata.
Chimica 2025: i reticoli molecolari che trasformano spazi invisibili
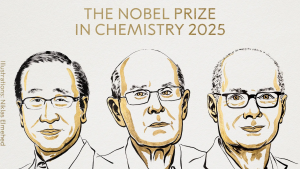
Susumu Kitagawa, Richard Robson and Omar M. Yaghi
Il Premio Nobel per la Chimica 2025 è stato assegnato a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi «per lo sviluppo dei reticoli metallorganici», noti come MOF (Metal-Organic Frameworks). Queste sono strutture molecolari composte da ioni metallici connessi da leganti organici in configurazioni cristalline porose, con ampi spazi interni attraverso cui gas e molecole possono muoversi, lasciando passare gas e altre sostanze.
Grazie ai loro studi, i chimici hanno creato decine di migliaia di MOF diversi, alcuni dei quali promettono soluzioni a sfide cruciali come la cattura dell’anidride carbonica, la purificazione delle acque dai PFAS, la degradazione di residui farmaceutici e persino la raccolta di acqua dall’aria nei deserti.
L’impatto ambientale e tecnologico di queste scoperte apre prospettive enormi per l’energia sostenibile e la protezione del pianeta.
Letteratura 2025: l’arte, il terrore e la parola resistente
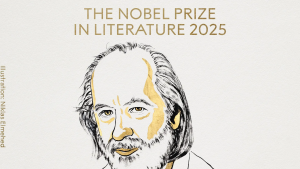
László Krasznahorkai
Il Premio Nobel per la Letteratura 2025 è stato conferito allo scrittore ungherese László Krasznahorkai, la cui opera esprime una tensione costante tra visione apocalittica e resistenza dell’arte. Il Comitato ha riconosciuto nella sua scrittura la capacità di riaffermare la potenza della parola “in mezzo al terrore apocalittico”.
Krasznahorkai, già celebre per romanzi come Satantango e Melancolia della resistenza, utilizza frasi lunghe e avvolgenti per costruire mondi narrativi complessi e disturbanti. Il suo Nobel rappresenta un tributo alla letteratura che interroga, che non consola ma scuote, e che chiede al lettore di confrontarsi con la condizione umana nella sua interezza. Con questo riconoscimento, la narrativa dell’Europa centrale riceve una nuova e meritata attenzione internazionale.
Pace 2025: il coraggio civile come strumento di libertà
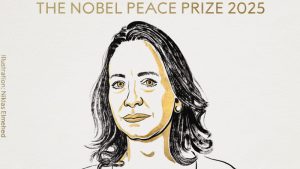
María Corina Machado
Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, per il suo impegno instancabile nella difesa dei diritti democratici e nella ricerca di una transizione pacifica in Venezuela.
Il Comitato norvegese ha sottolineato il suo coraggio civile, espresso nel continuare a operare in un contesto di repressione e minacce personali. Al momento dell’annuncio, Machado si trovava in clandestinità, simbolo vivente della fragilità ma anche della forza della resistenza non violenta.
Il premio rimette al centro del dibattito mondiale il valore della libertà politica, la dignità umana e la necessità di tutelare i processi democratici in contesti autoritari.
Economia 2025: crescita, innovazione e distruzione creativa

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt
Il Premio Nobel per le Scienze Economiche 2025 è stato conferito a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt «per aver spiegato la crescita economica guidata dall’innovazione» e il ruolo della tecnologia.
Mokyr è stato premiato per aver individuato i prerequisiti storici e sociali che favoriscono un progresso tecnologico duraturo, mentre Aghion e Howitt sono stati riconosciuti per la loro teoria della, che spiega come le nuove tecnologie sostituiscano quelle obsolete, generando sviluppo e competitività.
Le loro analisi mostrano che l’innovazione non è un processo spontaneo, ma il risultato di un ecosistema economico capace di sostenere la ricerca, promuovere la mobilità sociale e incoraggiare la concorrenza.
